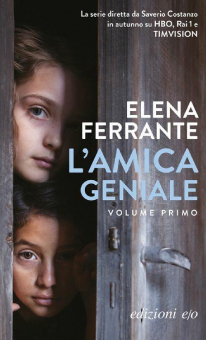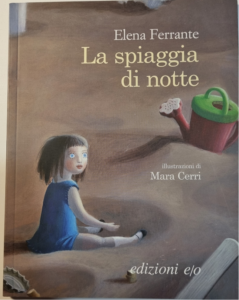Era stata colpa sua. In un tempo non troppo distante – dieci giorni, un mese, chi lo sa, ignoravamo tutto del tempo, allora – mi aveva preso la bambola a tradimento e l’aveva buttata in fondo a uno scantinato. Ora stavamo salendo verso la paura, allora ci eravamo sentite obbligate a scendere, e di corsa, verso l’ignoto. In alto, in basso, ci pareva sempre di andare incontro a qualcosa di terribile che, pur esistendo da prima di noi, era noi e sempre noi che aspettava. Quando si è al mondo da poco è difficile capire quali sono i disastri all’origine del nostro sentimento del disastro, forse non se ne sente nemmeno la necessità. I grandi, in attesa di domani, si muovono in un presente dietro al quale c’è ieri o l’altro ieri o al massimo la settimana scorsa: al resto non vogliono pensare. I piccoli non sanno il significato di ieri, dell’altro ieri, e nemmeno di domani, tutto è questo, ora: la strada è questa, il portone è questo, le scale sono queste, questa è mamma, questo è papà, questo è il giorno, questa la notte. Io ero piccola e a conti fatti la mia bambola sapeva più di me. Le parlavo, mi parlava. Aveva una faccia di celluloide con capelli di celluloide e occhi di celluloide. Indossava un vestitino blu che le aveva cucito mia madre in un raro momento felice, ed era bellissima. La bambola di Lila, invece, aveva un corpo di pezza gialliccia pieno di segatura, mi pareva brutta e lercia. Le due si spiavano, si soppesavano, erano pronte a scappare tra le nostre braccia se scoppiava un temporale, se c’erano i tuoni, se qualcuno più grande e più forte e coi denti aguzzi le voleva ghermire.
Giocavamo nel cortile, ma come se non giocassimo insieme. Lila era seduta per terra, da un lato della finestrella di uno scantinato, io dall’altro. Ci piaceva, quel posto, innanzitutto perché potevamo disporre, sul cemento tra le sbarre dell’apertura, contro il reticolo, sia le cose di Tina, la mia bambola, sia quelle di Nu, la bambola di Lila. Ci mettevamo sassi, tappi di gassosa, fiorellini, chiodi, schegge di vetro. Ciò che Lila diceva a Nu io lo captavo e lo dicevo a voce bassa a Tina, ma modificandolo un po’. Se lei prendeva un tappo e lo metteva in testa alla sua bambola come se fosse un cappello, io dicevo alla mia, in dialetto: Tina, mettiti la corona di regina se no prendi freddo. Se Nu giocava a campana in braccio a Lila, io poco dopo facevo fare lo stesso a Tina. Ma non succedeva ancora che concordassimo un gioco e cominciasse una collaborazione. Persino quel posto lo sceglievamo senza accordo. Lila andava lì, e io girellavo, fingevo di andare da un’altra parte. Poi, come se niente fosse, mi disponevo anch’io accanto allo sfiatatoio, ma dal lato opposto.
La cosa che ci attraeva di più era l’aria fredda dello scantinato, un soffio che ci rinfrescava in primavera e d’estate. Poi ci piacevano le sbarre con le ragnatele, il buio, e il reticolo fitto che, rossastro di ruggine, si arricciolava sia dal lato mio che da quello di Lila, creando due spiragli paralleli attraverso i quali potevamo far cadere nell’oscurità sassi e ascoltarne il rumore quando toccavano terra. Tutto era bello e pauroso, allora. Attraverso quelle aperture il buio poteva prenderci all’improvviso le bambole, a volte al sicuro tra le nostre braccia, più spesso messe di proposito accanto al reticolo ritorto e quindi esposte al respiro freddo dello scantinato, ai rumori minacciosi che ne venivano, ai fruscii, agli scricchiolii, al raspare.
Nu e Tina non erano felici. I terrori che assaporavamo noi ogni giorno erano i loro. Non ci fidavamo della luce sulle pietre, sulle palazzine, sulla campagna, sulle persone fuori e dentro le case. Ne intuivamo gli angoli neri, i sentimenti compressi ma sempre vicini a esplodere. E attribuivamo a quelle bocche scure, alle caverne che oltre di loro si aprivano sotto le palazzine del rione, tutto ciò che ci spaventava alla luce del giorno. Don Achille, per esempio, era non solo nella sua casa all’ultimo piano ma anche lì sotto, ragno tra i ragni, topo tra i topi, una forma che assumeva tutte le forme. Lo immaginavo a bocca aperta per via di lunghe zanne d’animale, corpo di pietra invetriata ed erbe velenose, sempre pronto ad accogliere in un’enorme borsa nera tutto ciò che lasciavamo cadere dagli angoli divelti del reticolo. Quella borsa era un tratto fondamentale di don Achille, ce l’aveva sempre, an che in casa sua, e ci metteva dentro materia viva e morta.
Lila sapeva che avevo quella paura, la mia bambola ne parlava ad alta voce. Per questo, proprio nel giorno in cui senza nemmeno contrattare, solo con gli sguardi e i gesti, ci scambiammo per la prima volta le nostre bambole, lei, appena ebbe Tina, la spinse oltre la rete e la lasciò cadere nell’oscurità.
[…]
Ci vedevamo in cortile sempre più spesso. Ci mostravamo le nostre bambole ma senza darlo a vedere, l’una nei dintorni dell’altra, come se fossimo da sole. A un certo punto le facemmo incontrare per prova, per vedere se andavano d’accordo. E così arrivò il giorno che stavamo accanto alla finestra dello scantinato col reticolo scollato e facemmo uno scambio, lei tenne un po’ la mia bambola e io un po’ la sua, e Lila di punto in bianco fece passare Tina attraverso l’apertura nella rete e la lasciò cadere.
Provai un dolore insopportabile. Tenevo alla mia bambola di celluloide come alla cosa più preziosa che avessi. Lo sapevo che Lila era una bambina molto cattiva, ma non mi sarei mai aspettata che mi facesse una cosa così malvagia. Per me la bambola era viva, saperla in fondo allo scantinato, in mezzo alle mille bestie che ci vivevano, mi gettò nella disperazione. Ma in quell’occasione imparai un’arte in cui poi sono diventata molto brava. Trattenni la disperazione, la trattenni sul bordo degli occhi lucidi, tanto che Lila mi disse in dialetto:
«Non te ne importa?»
Non risposi. Provavo un dolore violentissimo, ma sentivo che più forte ancora sarebbe stato il dolore di litigare con lei. Ero come strozzata da due sofferenze, una già in atto, la perdita della bambola, e una possibile, la perdita di Lila. Non dissi nulla, feci solo un gesto senza dispetto, come se fosse naturale, anche se naturale non era e sapevo che stavo rischiando molto. Mi limitai a gettare nello scantinato la sua Nu, la bambola che mi aveva appena dato.
Lila mi guardò incredula.
«Quello che fai tu, faccio io» recitai subito ad alta voce, spaventatissima.
«Adesso me la vai a prendere».
«Se tu vai a prendere la mia».
Andammo insieme. […]